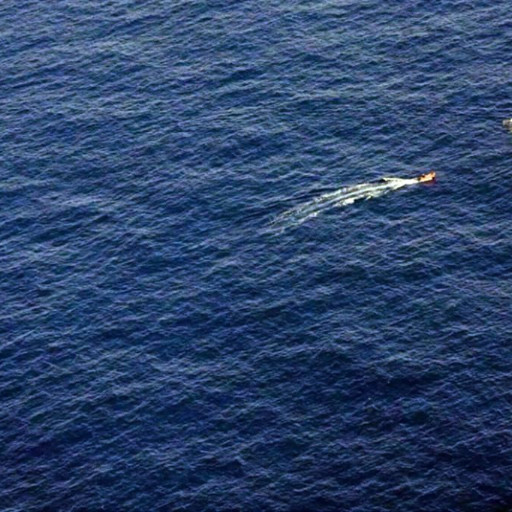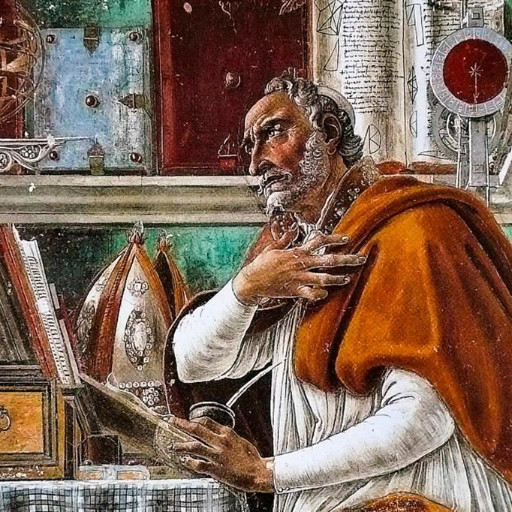Amoris laetitia, una svolta anche per la teologia morale
di
Alessandro Rossi
Con papa Francesco la base delle istanze morali non è più costituita dall’ordine funzionale della natura ma da un ordine personale di ricerca del senso. Lo spiega il teologo Antonio Autiero

Perché è importante tornare sugli insegnamenti e sulle riflessioni innescate dall’Esortazione postsinodale Amoris Laetitia (2016) in questi giorni di attesa per l’elezione del nuovo pontefice? Perché le questioni trattate da papa Francesco non entrano soltanto nel vivo del tema della famiglia, del matrimonio e dell’amore, ma toccano anche ambiti fondamentali della comprensione antropologica, teologica ed etica che rappresentano un punto di svolta nella teologia morale, facendo di essa non un codice di norme rigide e statiche, ma un luogo sapienziale, ricco di risorse per leggere i segni dei tempi, riconoscere nell’uomo e nel credente la dignità di soggetto etico, libero e responsabile, e prendere a cuore la condizioni reale della storia d’amore in cui ogni coppia si trova a vivere.
Da quasi sessant’anni nell’etica teologica è in atto un dibattito a proposito di questioni fondamentali riguardanti la fondazione delle norme, il rapporto tra principi generali e plausibili eccezioni, il carattere storico dell’esistenza umana e il ruolo della coscienza individuale e collettiva. E, non certo solo oggi, questioni di tal genere diventano particolarmente roventi quando si riferiscono a temi di etica sessuale e coniugale. Tuttavia, c’è qualcosa di nuovo nella situazione attuale. Per la prima volta dopo decenni, attraverso un documento come Amoris laetitia, è stata aperta la strada a un certo movimento in questioni di teologia morale, delle quali molti pensavano che fossero ormai definitivamente decise le sorti nel loro senso più profondo. Grazie a papa Francesco abbiamo capito che non può più essere escluso che, in determinate questioni dottrinali, si possa pervenire a veri e propri sviluppi. E quella dottrina, ritenuta immutabile, è realmente entrata in movimento. Amoris laetitia dev’essere compresa realmente del senso di un ulteriore sviluppo delle affermazioni fin qui fatte dal magistero della Chiesa, sul modo pastorale di rapportarsi ai divorziati risposati. Qui si tratta di non ritenere più che credenti in “situazione irregolare” di un secondo matrimonio si trovino perciò stesso in uno stato peccaminoso di rifiutodella legge di Dio.
E perché no? Perché – così ci dicono il documento pontificio e la nostra esperienza – anche una coppia risposata può essere una coppia di persone che si amano e nella fede si prendono cura uno dell’altra e insieme, nell’amore, si prendono cura dei loro figli. Ora, dato che non si deve necessariamente ritenere che persone divorziate e risposate che non vivono “come fratelli e sorelle” in nessun caso possono ricevere il sacramento della confessione e dell’eucaristia, nella questione dell’accesso ai sacramenti si deve necessariamente tenere in considerazione il loro giudizio di coscienza.
È evidente che la trama profonda di questo nuovo sguardo ispirato da Amoris laetitia passa anche attraverso una mutata sensibilità, sia di linguaggio che di ottica. La formula ricorrente di “situazioni irregolari”, viene introdotta da Francesco con l’appellativo di “cosiddette”. Non si tratta qui solo di un’attenuazione cosmetica o addirittura di una messa in dubbio della particolarità e problematicità di determinate situazioni. Piuttosto si invita a considerare la complessità di tali situazioni, già a partire dal motivo per il quale esse si presentano a noi in modo differenziato, secondo storie e circostanze proprie e specifiche di ognuna di esse. Ma sulla ragione intima di una simile “irregolarità” si viene chiamati ad essere sensibili, attenti e aperti al discernimento. Regolare o irregolare è necessariamente da riferirsi in modo esclusivo non alla sfera della legge, ma alla densità del significato del vissuto coniugale che entra in gioco.
Lo sviluppo rispettoalle posizioni fin qui sostenute dal magistero, è per papa Francesco ben radicato nell’alveo della teologia morale. Esso – come articolato in modo più ampio nel saggio Amoris leatitia. Un punto di svolta per la teologia morale? (San Paolo, 2017) curato da chi scrive - si basa sulla disponibilità e sulla capacità di discernimento, che per l’applicazione di precetti morali sono di essenziale importanza, secondo l’adagio bene iudicat, qui bene distinguit (giudica bene chi sa ben distinguere). Discernere vuol dire porsi la domanda se si asseconda l’intenzione di un precetto a condizione che sempre e in ogni caso si agisca secondo il dettato materiale del precetto stesso. Possono esserci situazioni nelle quali noi, rispondendo alla nostra coscienza, possiamo agire anche in difformità al dettato materiale di quanto un precetto a prima vista possa richiederci. Perciò sarebbe un errore pensare che basti che un precetto di condotta morale venga semplicemente formulato e il resto sia una questione di obbligo a seguirlo ed applicarlo. “Il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato (Mc, 2,27) non significa altro che i precetti sono fatti per far del bene alle vite delle persone, e non viceversa.
Papa Francesco ci ha messo in guardia a giusta ragione contro un modo di pensare secondo il quale l’applicazione obbediente delle leggi, nel senso di seguirne il dettato materiale, sia già di per sé sempre garanzia di agire nel modo moralmente giusto. Secondo papa Francesco, la Chiesa a partire dal suo modo di comprendere la misericordia, deve sempre chiedersi se le sue dottrine morali facciano realmente bene alle persone, nelle loro diverse situazioni di vita, oppure se esse, forse in modo ingiusto, non addossino alle persone pesi difficilmente sopportabili. Questo appello alla competenza discrezionale valorizza il luogo proprio della coscienza morale, sacrario dell’incontro dell’uomo con Dio, con sé stesso e con la comunità, come ci insegna Gaudium et spes (nr. 16). In questo sacrario della coscienza impariamo l’urgenza di trovare una risposta adeguata a ciò che chiamiamo “situazione irregolare” nelle quale le persone possono venire a trovarsi, non in base a un giudizio morale di valore che è stato definito già prima. Già nei decenni precedenti il grande teologo morale Bernard Haring scriveva: «Le situazioni pastorali hanno bisogno del dono del discernimento».
Papa Francesco ci ha detto in modo chiaro che la soluzione pastorale per i divorziati risposati contenuta in Amoris laetitia, è senza dubbio conciliabile con la legge di Dio, con l’istanza della misericordia e con il concetto cristiano della coscienza formata. I divorziati risposati possono ricevere i sacramenti della penitenza e dell’eucaristia, quando per loro si configura quello che Amoris laetitia dice circa il discernimento etico sulla loro situazione di vita, condotto in modo differenziato e accurato. «Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante» (AL 301). Per Papa Francesco sarebbe quindi una restrizione moralmente problematica affermare in modo automatico che una persona divorziata e risposta vive in stato di peccato mortale, unicamente a partire dal fatto che essa si trova in una situazione che non corrisponde a una norma della Chiesa.
Già il Vaticano II aveva detto che la sessualità deve prendere una forma veramente umana, cioè “da persona a persona” (Gs 49), superando, quindi, una finalità strettamente naturalistica che permea la sessualità. Perciò proseguire sulla scia del Concilio in un approccio decisamente personalistico, come fa Amoris laetitia, non ha a che vedere con il fatto che si rinuncerebbe a definire ciò che è lecito o non lecito fare. Solo che con l’insegnamento del Concilio e di Papa Francesco il criterio è cambiato. La base delle istanze morali incondizionate non è più costituita dall’ordine funzionale della natura, ma da un ordine personale di ricerca del senso. Ciò che non è lecito, ha a che fare con tutto ciò che lede la dignità delle persone, offende i loro diritti e ferisce la fioritura delle loro relazioni.
Ecco la grande eredità che papa Francesco, con Amoris laetitia, lascia alla teologia morale ma anche al magistero del futuro pontefice. Evitando di credere che tutte le questioni teologiche legate al matrimonio, alla coppia e all’amore siano chiuse e risolte una volta per sempre, in un ordine morale oggettivo, al quale al massimo si possono applicare accomodazioni pastorali più morbide, egli ci offre spunti preziosi per continuare la ricerca e avanzare sulla via della comprensione della dottrina morale che tenga il suo centro gravitazionale sulla sacralità della persona. E questo apre senza dubbio a nuove speranze!
*professore emerito di teologia morale all’Università di Münster (Germania)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Temi